

 |
“CATANZARO delle tre V”: da Vitaliano (Santo
patrono della città), velluti (fu centro serico fin dal tempo dei Normanni) e
venti (per le continue brezze provenienti dalla Sila e dal mare).
Città antichissima, Catanzaro domina dall’alto di uno sperone roccioso,
tagliata in due dal profondo vallone della Fiumarella. Ad unire le due sommità
c’è il colossale viadotto in cemento armato ad unica arcata, tra i più alti
del genere in Europa, costruito nel 1960 su progetto dell’architetto Riccardo
Morandi.
La via migliore per raggiungere Catanzaro è l’Autostrada del Sole A3, fino a Lamezia Terme, da dove si imbocca la Superstrada
280 che porta al capoluogo.
Da Reggio Calabria (e dalla Sicilia), tuttavia, un’alternativa panoramica è la
Statale 106, che segue la costa jonica.
La stessa strada, nella direzione opposta, è la migliore possibile per chi
proviene dalla Puglia o dal Sud della Basilicata.
 |
 |
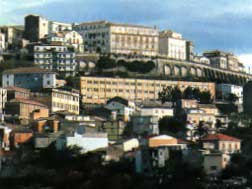 |
Catanzaro fu fondata dai Bizantini alla fine
del IX-X sec., mentre intorno le coste venivano sconquassate dall’avamposto
Saraceno, al comando di Abstaele insediatosi a Squillace. La Città fu punto
strategico delle operazioni del condottiero bizantino Niceforo Foca, ai tempi
del califfo Abramo.
Conquistata dai Normanni con Roberto il Guiscardo, fu
conosciuta come Catacium, e vi fu eretto un castello-fortezza che si può ancora
ammirare.
Catanzaro assunse grande importanza sotto il regno di Goffredo nel
1131 e, dopo il 1254 con Guglielmo, un fedele dello svevo Manfredi. Nel 1406 la
Città, per intercessione di Ladislao, ebbe i privilegi di dominio regio che
continuò a mantenere anche con la dominazione aragonese.
Fu sede, a partire dal
XVI sec., di importanti industrie seriche ed i maestri della tessitura si
recavano in Francia, a Tours, ad insegnare la propria arte.
La peste del 1562 colpì un gran numero di persone, circa 5000 impiegate nelle filande,
fiorente imprenditoria che si andò ad eclissare gradatamente dopo la metà del
XVIII secolo. I terremoti del 1638 e del 1783 arrecarono danni assai gravi. Il
primo in particolare, arrecò gravi danni al patrimonio artistico.
Ai tempi della
dominazione Borbonica Catanzaro divenne capoluogo amministrativo della Calabria
Ulteriore ed attualmente è Capoluogo Regionale.
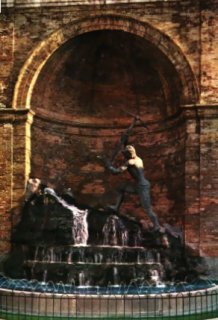 |
Alla fine del Regno Borbonico, Catanzaro con una popolazione di 22.000 abitanti,
era chiusa negli stretti confini naturali. A nord la città era chiusa dalla Porta di
Terra, e a sud il contrafforte si estendeva a terrazzi degradanti fino
a località Sala.
Dopo l’unità il Parlamento nazionale riconobbe importanti funzioni alla città
e ciò determinò la necessità di adeguare le strutture viarie, ed abitative al
nuovo ruolo che le veniva affidato. Nella città infatti, dopo gli interventi
effettuati nel periodo dei Borboni, si era verificata una stasi nel settore
delle opere pubbliche e l’instabilità politica del Risorgimento aveva
determinato un accentuarsi di questa condizione. La classe politica emergente si
fece portatrice di un progetto di sviluppo della città, ispirandosi ai modelli
forniti dalle esperienze condotte in Europa tese al rinnovamento di centri
urbani di antica formazione. La volontà di rinnovamento era determinata anche
da problemi di carattere igienico-sanitario. Nel 1863 prende corpo l’idea di un
progetto di intervento complessivo nel centro urbano; viene così nominata una
commissione formata da Michele Manfredi, Vincenzo Parisi e Pasquale Gigliotti,
incaricati di far “cambiar sembianze” alla città. Successivamente
viene approvato il PRG che presenta un progetto di sistemazione dell’intero
abitato.
La relazione che illustrava il progetto di risanamento fu redatta da Manfredi,
che nel 1871 diverrà l’esecutore del Piano attraverso l’ufficio tecnico
comunale. Il progetto riguardava tutto l’abitato, misurando gli interventi a
seconda dell’importanza delle vie e delle opere previste.
In primo luogo,
bisognava intervenire sulle vie d’accesso alla città e, a questo scopo venne
ripreso il progetto di demolizione della Porta di Mare. Vennero specificati
chiaramente i motivi della demolizione ma dubbi sull’opportunità di eseguire il
progetto, ne impedirono l’effettuazione (Porta di mare sarà demolita nel 1930).
A sud si progettò la sistemazione della via Bellavista, denominata “la villa”, che si trovava nell’estremo limite dell’abitato. Si
progettò la creazione di un percorso Belvedere che prevedeva la demolizione
della “cona”, detta anche l’arco della villa, un’antica immagine sacra
su arco che delimitava la strada. Attraverso questo progetto di demolizione, si
attuava la cancellazione di quei segni di arte spontanea che
caratterizzavano le vie d’accesso alla città in favore di un’organizzazione
urbana, a volte priva di identità.
A nord si progettò il taglio della rocca su cui si trovava il Castello, per
rettificare la strada che legava Catanzaro al comprensorio agricolo di Nicastro
e alla strada delle Calabrie. I lavori più gravosi vennero previsti per corso
Vittorio Emanuele. Il corso, che non superava la larghezza di 8 metri, e spesso
ne misurava 5, era percorribile con difficoltà dal traffico delle carrozze e
non offriva possibilità di adeguata collocazione delle attrezzature commerciali
ed amministrative. Si progettò quindi la rettificazione e l’allargamento della
sede stradale, con la demolizione delle facciate e di parte dei corpi di
fabbrica sul lato orientale dell’asse.
Inoltre si progettò l’intervento sulle vie laterali al corso principale: via
Monte e via Poerio. Per queste strade furono previste solo brevi rettifiche ed
allargamenti. Il modello urbano a cui si faceva riferimento era simmetrico e
regolare ma i progetti erano limitati dalle ristrette capacità finanziarie del
comune e dall’altimetria della città.
I lavori procedettero con molta lentezza; nonostante la legge sulle
espropriazioni per pubblica utilità, il comune si avvalse di una legge
Borbonica sulla contrattazione privata per l’acquisto di alcuni edifici. Così
nel 1869 venne acquistata la casa di Domenico Corrado dove sorgerà, eseguiti
lavori di arretramento e allargamento, il palazzo di Achille Fazzari. Si
avviarono anche le trattative per l’acquisto di due fabbricati (Greco e Le Pera)
e di alcuni caseggiati (Pupa, Franco e Maruca) e si avviarono le procedure di
esproprio di un fabbricato (Augusto-Rizzonelli) a S. Rocchello, che costituiva
una strozzatura lungo il corso.
A causa dell’insufficienza dei mezzi finanziari i lavori però si limitarono al
ribassamento stradale tra Liceo Galluppi e chiesa S. Giovanni e alla
sistemazione di via Cavour, che serviva da collegamento con via Principe Umberto
e piazza S. Caterina.
Gli elaborati relativi allo sventramento del corso sono stati
in gran parte dispersi ma una ricostruzione degli avvenimenti è possibile
grazie alle relazioni comunali del 1877 e ad alcuni stralci del progetto e
perizie di esproprio. Quarantaquattro corpi di fabbrica dovevano essere
interamente o parzialmente demoliti, per lo più si trovavano sul lato orientale
del corso, mentre sul lato occidentale bisognava attuare un parziale
allineamento.
Nel 1879 furono espropriati i fabbricati tra Palazzo Fazzari e piazza Mercanti (oggi
piazza Grimaldi), quest’ultima, insieme con p.S. Caterina e p. Immacolata,
rappresentava un luogo di ritrovo della borghesia locale.
Nel 1896 venne presentata una petizione affinché l’area tra p. Mercanti e corso V. Emanuele fosse destinata a suolo pubblico. Sul
lato occidentale del corso si prevedeva l’espropriazione di Palazzo Grimaldi,
che doveva essere demolito ed arretrato di circa 7,5 m..
Nel 1880 i lavori relativi al tratto tra Palazzo Fazzari e p. Matteotti erano già
a buon punto; nel 1881 si ottenne il decreto di pubblica utilità per il tratto
tra Palazzo Fazzari e porta di Mare, si progettava l’allineamento di Palazzo
Ruggeri (oggi Palazzo Raffaelli), la sistemazione della scalinata della chiesa
di S. Francesco, e l’allineamento del convento di S. Rocco (adibito da tempo a
caserma).
Dall’altro lato della strada si demolirono le facciate di due fabbricati (Asturi).
Il punto più difficile da sistemare era tra S. Rocchello e p. S. Caterina, dove
bisognava operare un taglio consistente dei fabbricati su ambedue i lati del
corso; lavori che si protrarranno a lungo nel tempo a causa dei ricorsi dei
privati. In quell’area era prevista la costruzione del palazzo dell’Intendenza
di Finanza che verrà edificato nel primo decennio del 1900. Nel 1899 si
effettuerà il taglio della facciata del Real liceo Galluppi.
I progetti dello sviluppo della città ripresero vigore con l’avvento del
fascismo, anche se l’attività edilizia nella città, in questa prima fase, non
aveva raggiunto lo stesso grado di espansione di molte altre città Italiane.
Nel 1932-1933, il Podestà dell’epoca, Larussa, conferì a Marcello Piacentini,
massimo esponente dell’architettura di regime, l’incarico di progettare, lì
dove sorgeva il quartiere di Paesello, la sistemazione della piazza. Tale
progetto, dai documenti pervenutici, prevedeva la costruzione di una galleria
civica, di un nuovo teatro, di strutture amministrative, abitazioni e servizi nonché
la nuova Casa del Fascio; purtroppo motivi di ordine finanziario e le
mutate condizioni di politica interna, portarono alla non realizzazione di tale
progetto.
L’attuazione dello sventramento del Paesello si effettuava in
seguito all’approvazione di un piano regolatore parziale dell’ area compresa tra
piazza Prefettura, Vico Preti, via Raffaelli e chiesa Immacolata, approvato con
legge 29/5/1939 n. 962. Nel 1936 fu possibile realizzare la costruzione dell’Istituto Nazionale di Assicurazioni, unico edificio ad essere completato
nell’epoca Fascista; mentre il Palazzo delle Poste e la sede dell’Amministrazione Provinciale verranno realizzati dopo la seconda guerra
mondiale.
Nel 1943 i bombardamenti avevano danneggiato tutto l’asse principale del nucleo
storico, la zona a nord tra piazza Garibaldi e il liceo Galluppi, interessando
anche via Poerio e Settembrini, e la zona centrale tra il Palazzo della
Prefettura e vico Preti, via Raffaelli e chiesa della Immacolata. Venne così
elaborato un piano d’emergenza finalizzato alla ricostruzione dei manufatti
edilizi distrutti che si proponeva di dettare criteri e norme che non fossero in
contrasto con lo sviluppo futuro della città.
Il piano di ricostruzione di Catanzaro, redatto dall’Architetto Francesco
Armogida, veniva adottato dal consiglio comunale il 17/12/1947 e approvato dal
Ministero dei Lavori Pubblici l’anno successivo.
Gli interventi previsti riguardavano essenzialmente tre zone: il nucleo storico,
la frazione Marina e le nuove zone di espansione. Le demolizioni causate dai
bombardamenti, costituirono elemento di accelerazione per lo sventramento del
corso iniziato ormai da quasi un secolo.
La zona a nord di corso Mazzini aveva ancora nella parte più ristretta,
antistante Palazzo Mannella, una sezione stradale di 5 metri di ampiezza, tra
Palazzo Susanna e il liceo Galluppi la sezione stradale era compresa tra 5 e 7,5
metri. Il piano di ricostruzione prevedeva un arretramento delle facciate dei
palazzi prospicienti, e l’ampliamento della sede stradale a 14 metri, in seguito
ridotta per il ricorso presentato da Antonio Susanna il quale si opponeva all’abbattimento della facciata del palazzo omonimo risalente al XVII secolo;
si interveniva con l’arretramento delle facciate dei fabbricati distrutti, allo
scopo di rendere più agevole la circolazione stradale.
Il progetto di ampliamento della sede stradale del corso principale verrà
ultimato nel 1975 con l’abbattimento del comparto edilizio Serravalle e Cumis,
tra piazza Grimaldi e l’Immacolata.
 |

Città capoluogo dell’omonima provincia e della Calabria, situata a 320 m s.m. sul versante ionico dei rilievi calabresi immediatamente a S della Sila, non lontano e in vista del golfo di Squillace. Comune di 111,34 km2 con 103.500 abitanti . L’abitato si stende con struttura raccolta e rete viaria alquanto irregolare su uno sprone roccioso, delimitato dalle profonde valli percorse dai torrenti Musofalo e Fiumarella, che più a valle confluiscono insieme; i versanti vallivi sono ripidi e impervi tranne a SE, dove il pendio terrazzato digrada verso il piano formato dalla confluenza delle due fiumare. A NW lo sprone è collegato mediante uno stretto istmo, su cui si trova piazza Matteotti, alle estreme propaggini collinari della Sila merid., sulle quali si stendono i quartieri più recenti, iniziati nel 1909 con la costruzione del rione Milano, affiancato in seguito dal rione San Leonardo. Gravemente danneggiato dai terremoti del 1638 e del 1783, l’abitato fu soggetto a partire dal 1870 a un profondo e radicale rinnovamento edilizio e a una nuova organizzazione urbanistica, che portò all’apertura del lungo corso Mazzini, la maggiore arteria longitudinale cittadina, e del giro di strade lungo il margine del primitivo nucleo abitato, che in precedenza si affacciava direttamente sui ripidi pendii scoscesi verso il corso delle due fiumare. La costruzione della Strada dei Due Mari e dell’ardito viadotto sulla Fiumarella ha dato inizio all’espansione dell’abitato verso W e SW, al di là della valle percorsa dalla Fiumarella. Fra i centri principali nel territorio comunale è Catanzaro Marina, frequentata stazione balneare, sulla costa ionica, tra le foci della Fiumarella e del Corace. Negli ultimi anni l’espansione del centro di Sala e di un asse edilizio verso lo Ionio permette di considerare anche la frazione costiera di Catanzaro Marina come un estremo quartiere della città. La struttura economica di C. è fragile, incentrata solo sul terziario e, in particolare, sulle attività della pubblica amministrazione e del commercio al minuto. Debole l’industria: prevalgono i settori connessi con le produzioni agricole o con l’edilizia; qualche limitato sviluppo industriale si è verificato a Catanzaro Marina. Un peso notevole nell’economia locale hanno tuttora l’agricoltura (cereali, barbabietole da zucchero, ortaggi, frutta, agrumi, uva da vino, olive, noci), l’allevamento del bestiame e lo sfruttamento forestale. Uno sviluppo ancora precario caratterizza il turismo. La città è sede arcivescovile.
Fondata dai Bizantini alla fine del sec. IX a difesa contro i Saraceni, divenne contea coi Normanni di Roberto il Guiscardo (1059) e centro importante per l’industria serica. Passata al demanio regio, dal 1252 fu infeudata ai Ruffo da Federico II e successivamente ai Caraffa e ai Soriano. Sotto il dominio spagnolo decadde a causa dell’oppressivo fiscalismo, mentre in età napoleonica divenne il più importante centro della regione, sede di università. Fu centro importante anche sotto i Borbone. Prese parte attiva ai moti del 1820-21, del 1848 e del 1860. Con l’unità ebbe a risentire le conseguenze del contatto improvviso con l’Italia sett. e fu uno dei focolai del brigantaggio. Il movimento popolare prevalentemente contadino vi ebbe poi rigoglioso sviluppo (occupazione delle terre, lotte per i patti agrari) e per qualche tempo resistette anche al fascismo.
La provincia di C. (80 comuni; 2392 km2; 316.146 ab.) in seguito all’istituzione
(1992) delle nuove province di Crotone e Vibo Valentia, promossa in base alla
legge di riforma delle autonomie locali (n. 142, giugno 1990), ha subito un
decisivo ridimensionamento territoriale. Attualmente comprende buona parte del
settore centrale della Calabria; bagnata a W e a E rispettivamente dai mari
Tirreno e Ionio, che formano qui le ampie falcature dei golfi di Sant’Eufemia e
di Squillace, confina a N con la prov. di Cosenza, a NE con la prov. di Crotone
e a S con quelle di Vibo Valentia e Reggio di Calabria. La morfologia del
territorio è molto varia, in quanto alterna zone montuose, collinari e
pianeggianti. Nella parte sett. si innalzano i rilievi della Sila Piccola, vasto
altopiano ondulato e ricoperto da boschi di agrifogli e di latifoglie. A S della
strozzatura costituita dal cosiddetto istmo di Catanzaro o di Squillace
(insellatura di Marcellinara, 251 m), si innalzano i rilievi delle Serre, che si
spingono verso SW fin oltre il confine della provincia. Il clima è tipicamente
mediterraneo lungo le fasce costiere, più calda quella ionica ma meglio
irrorata dalle precipitazioni quella rivolta al Tirreno, mentre sui rilievi dell’interno prevalgono condizioni climatiche continentali, attenuate però
dalla vicinanza del mare e dalla posizione del territorio. Le precipitazioni,
che presentano un massimo nei mesi invernali e un minimo piuttosto marcato in
quelli estivi, sono copiose nelle aree più elevate (1900 mm annui) mentre in
quelle pianeggianti scendono a valori assai più modesti (700 mm annui).
I corsi
d’acqua, anche quelli maggiori, hanno tutti regime torrentizio per la siccità
dei mesi estivi: i principali sono il Tacina e il Corace sul versante ionico, il
Savuto e il Lamato su quello tirrenico. La popolazione, dopo aver registrato a
lungo una fase di diminuzione a causa dell’intenso fenomeno migratorio, mostra
una netta inversione di tendenza, con l’orientamento a concentrarsi nel
capoluogo; centro principale, oltre il capoluogo, è Lamezia Terme. L’agricoltura
(cereali, patate, ortaggi, frutta, barbabietole da zucchero, olive, uva da vino)
è, tra le attività della popolazione, la principale e la più progredita; essa
contribuisce in misura consistente alla formazione del reddito: in particolare, la
piana di Sant’Eufemia, in seguito a profonde trasformazioni irrigue e colturali,
è divenuta una delle aree di maggiore intensità colturale della regione,
nonostante i fenomeni di urbanizzazione in atto, la realizzazione dell’aeroporto
di Lamezia Terme e altre strutture industriali abbiano sottratto all’agricoltura
superfici sempre più estese. Minor interesse presentano, invece, l’allevamento
del bestiame, la pesca e le attività commerciali. L’industria è attiva nei
settori alimentare, conserviero, dei materiali da costruzione, chimico e
metallurgico (zinco, cadmio), settori questi ultimi due che hanno avuto un
recente e reale sviluppo. I maggiori impianti industriali sono localizzati nel
capoluogo. Negli ultimi anni il turismo, sia delle zone costiere sia delle aree
interne, ha registrato accentuati tassi di sviluppo, grazie anche al sensibile
miglioramento delle comunicazioni.